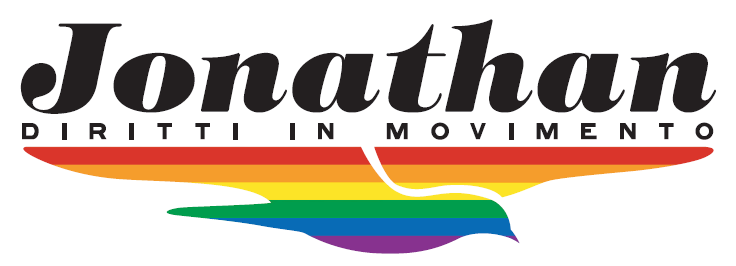Il Pride
E anche quest’anno la parata del Gay Pride, seguita dalle solite polemiche, è passata. Grazie a dio!
Ora che la tempesta è dietro le nostre spalle, anche io, come molti, voglio riflettere un po’, e dare le mie considerazioni, esporre i miei dubbi, porgere le mie domande, sperando di trovare risposte soddisfacenti.
Ma iniziamo con un avviso ai naviganti: per tutti voi che andate al Pride perché così potete conoscere altre persone, vedere bei culi e bei fighi, sperare di fare una bella trombata in serata, sappiate che sono totalmente d’accordo con voi, e pertanto vi dico che non avete nulla di più da sapere sul Pride, siete dispensati dal leggere ciò che segue.
Il Pride, a detta di molti, serve per far vedere che esistiamo anche noi, che anche noi vogliamo avere tutti i nostri diritti, che anche noi possiamo essere orgogliosi della nostra situazione. Sarebbe, per così dire, un coming out nazionale. Servirebbe, poi, a far pressione sui politici, a far conoscere all’uomo della strada chi siamo, a ricordare un anniversario importante, a esprimere e a far vedere la nostra cultura, ecc. ecc…
Certo, dobbiamo far vedere che esistiamo, e questo non è un discorso valido a livello nazionale, ma personale. Il coming out è una passaggio importantissimo (stavo quasi per dire “obbligatorio”) per tutti gli omosessuali. Per me è stato come nascere una seconda volta, come aver trovato finalmente un posto mio su un autobus affollatissimo dove tutti stanno seduti. Certo è stato doloroso, e tutt’ora continua a esserlo e non solo per me, ma anche per la mia famiglia, ma, ripeto, se dovessi vivere di nuovo la mia vita, lo rifarei, sempre e comunque.
Ma il coming out non è cosa da prendere alla leggera. E soprattutto è un rivelatore di falsità e ipocrisie. Dire che il Gay Pride serve da coming out è, in definitiva, camminare sul filo del rasoio. Sì, perché a che serve fare il proprio coming out al Pride di Grosseto quando non lo si è fatto a casa propria, nella propria città, in mezzo alla propria gente, tra i propri amici?
Troppo spesso il Pride è una sorta di sfogo per persone che poi, passato il 28 giugno, tornano alla vergogna quotidiana. E sì, perché e facile andare a scheccare in un paese dove nessuno ti conosce e dove, quindi, puoi fare quello che vuoi, tanto non dovrai renderne conto. E, poi, tanto è solo per un giorno o due… Ragionamento comodo, è vero, ma codardo.
Il Pride, inteso come coming out personale, bisognerebbe farlo a casa propria. Perché nessuno grida lo slogan «Un Pride in ogni città!»? Ma ci pensate? Il 28 giugno ogni città avrebbe il suo Pride in contemporanea con tutte le altre città italiane! Persino i giornali non potrebbero evitare di parlarne.
E poi, perché limitarsi a un solo giorno? Diciamo che vogliamo far conoscere a tutti chi siamo, cosa facciamo, che vogliamo esprimere la nostra cultura. Perché solo un giorno all’anno?
E perché mai dovremmo poi riunirci per poter esprimere la nostra cultura? Non possiamo essere orgogliosi da soli, casomai girando per il nostro paesino avvolti nella bandiera arcobaleno?
È anche vero, però, che il Pride ha una funzione politica di pressione. Sacrosanto, ma perché allora andiamo girando per l’Italia? La politica è a Roma, al Quirinale, all’Esquilino, a Palazzo Chigi, alle mura del Vaticano. Lì dobbiamo colpire più forte, non a Grosseto o a Bari. Mi si dirà che poi, a Bari o a Grosseto, mai sapranno di noi. Ebbene, è compito delle organizzazioni omosessuali di Grosseto o della Toscana far conoscere a Grosseto e alla Toscana la realtà omosessuale di Grosseto e della Toscana, il compito delle organizzazioni omosessuali nazionali è di portare alla politica (e cioè a Roma) la realtà omosessuale italiana.
I tempi sono maturi per una Gaia (e Incazzatissima) Marcia su Roma.
Secondo avviso ai naviganti: se quello che avete letto fino a ora vi ha reso euforici e avete voglia di andare fuori casa a sventolare la vostra bandiere arcobaleno, potete andare, siete dispensati dal leggere ciò che segue. Lascio andar via gli euforici, le “torce di sacra ira”, perché ciò che segue sarebbe una secchiata d’acqua fredda: gli omosessuali per lo più se ne fregano di manifestare, se ne fregano dei loro diritti e della loro condizione, se ne fregano del coming out e preferiscono restare nell’ombra che li protegge. Pochissimi sono gli omosessuali che partecipano ai gruppi, alle associazioni, alle manifestazioni. Sono molti di più, invece, quelli che sono eterosessuali per tutto il giorno e poi a notte, come vampiri, cambiano la loro livrea e vanno in discoteche, saune, boschetti fuori mano, parchi cittadini, luoghi isolati. Sia chiaro, non gliene faccio una colpa perché tanti anni (compresi quelli tanto delicati della maturazione psico-sessuale) vissuti nella vergogna e nella paura non sono facili da cancellare con un colpo di spugna, ma ne faccio un monito per le associazioni, le organizzazioni e per tutti coloro che hanno raggiunto un grado di autocoscienza più alto: bisogna rispettare coloro che vivono nascosti e bisogna cercare per quanto possibile (senza rovinargli la vita) di renderli coscienti di sé.
Insomma, il Pride non dovrebbe partire dall’alto, ma dal basso, dalle realtà locali, dai singoli che, risvegliati da un torpore fradicio di sesso, si rendano conto di essere esseri umano che hanno una dignità pari agli altri, che hanno una storia collettiva alle loro spalle, che ci sono eserciti che hanno bisogno di loro come di acqua fresca.
Terzo avviso ai naviganti: qui finisce la mia considerazione pratica. Ciò che segue è una constatazione teorica che mi toglie il sonno da qualche tempo a questa parte. Chi avesse tempo di leggerlo, può farlo, chi ha altro di meglio da fare, vada pure.
Quando penso al Gay Pride, non posso fare a meno di arrivare agli scritti di Michail Bachtin, di Jacques Lacan, di Victor Turner, di Clara Mucci e di altri.
Bachtin scrive, in L’opera di Rabelais e la cultura popolare (Einaudi, 1979), che nel Medioevo e nel primo Rinascimento c’erano dei momenti particolari (come per esempio il carnevale) dove tutte le regole “ufficiali” della società venivano meno, rivelando un aspetto dell’uomo e dei rapporti umani basato sul principio comico (riso, gioco). Durante il carnevale il «popolo penetrava temporaneamente nel regno utopico dell’universalità, della libertà, dell’uguaglianza e dell’abbondanza» (p. 12); venivano abolite le gerarchie e veniva creato un tipo speciale di comunicazione libero dalle regole dell’etichetta e della decenza e basato sulla logica del “mondo alla rovescia”.
Poi si è arrivati a pensare che questi momenti, chiamati “momenti di misrule” (letteralmente di «malgoverno», o, meglio, di «mancanza di governo»), fossero in realtà una anti-struttura prevista e organizzata dalla struttura. Il meccanismo, comparabile alla negazione freudiana, è abilmente spiegato da Babcock (e riassunto in Liminal Personae di Clara Mucci, ESI, 1995, p. 29). Ne risulta che questi momenti sono una specie di valvola di sfogo in cui ci si libera di tutte le tensioni accumulate dall’adesione alla Norma.
Da questo punto di vista, i Gay Pride sarebbero momenti in cui noi, proprio come scrive Bachtin, eliminiamo tutte le gerarchie e tutte le diversità, scherziamo e ridiamo, creiamo un nostro mondo alla rovescia (in cui non proviamo più vergogna di noi, ma l’esatto contrario, orgoglio), utilizziamo nuovi metodi di comunicazione (spesso ritenuti immorali e indecenti, basati per lo più sull’esibizione dei nostri corpi nudi). Ma finito questo momento, torniamo alla norma, alla repressione, alla vergogna, ai vestiti, alla serietà, all’ufficialità.
Bachtin scrive che il Carnevale non ha spettatori, perché tutti vi prendono parte. Al Pride, purtroppo, di spettatori cene sono molti (nelle strade, alla televisione o davanti al giornale). È vitale per noi coinvolgere tutti, eterosessuali compresi, in una cultura alternativa a quella dominante.
Per ora noi, in quanto anti-struttura, siamo solo un serbatoio di potenziali alternative, di potenziale nuova cultura. Nostro compito è rendere effettivo ciò che siamo in potenza.